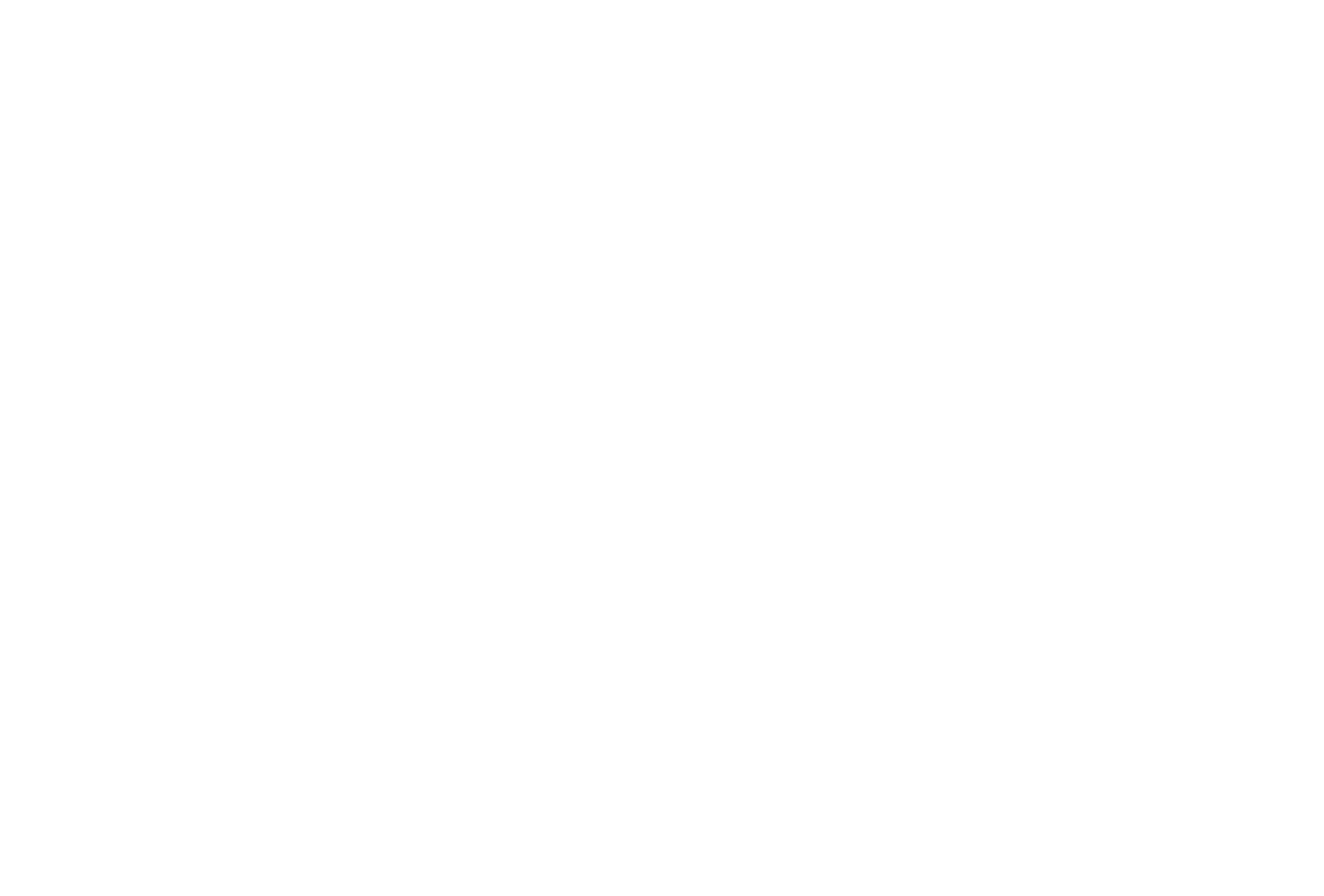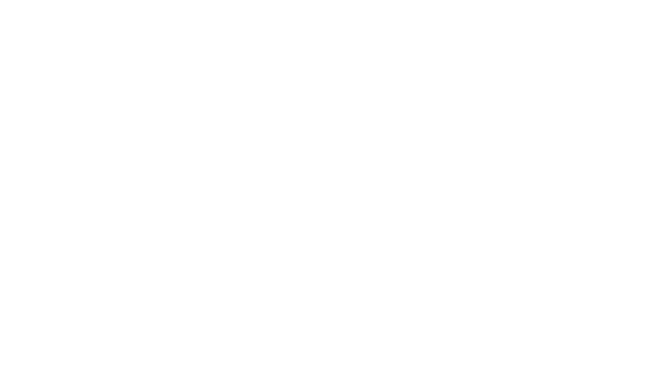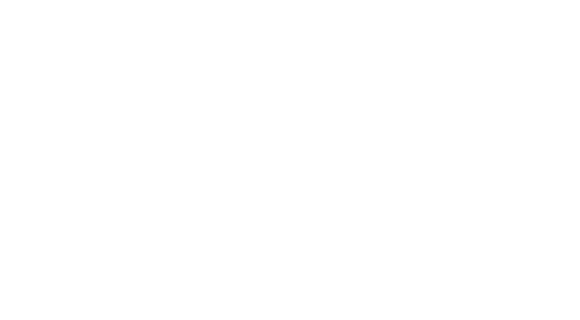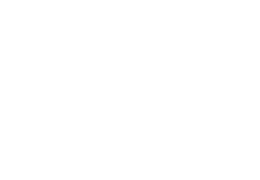Aranna Meschia nata e cresciuta a Genova dove ho studiato lingue, mi sono ben presto accorta che la Superba mi stava un po’ stretta all’alba dei tumultuosi 17 anni. Dopo la maturità mi sono trasferita a Londra, ho studiato Film e Scrittura Creativa, e poi ho lavorato nella produzione video per cinque anni. Lo stress accumulato di Londra e una separazione molto sofferta mi hanno spinto a perseguire il volontariato, prima in Francia e a Londra, poi in Malawi. Dopo un anno, ho finalmente abbracciato la mia passione per la scrittura, e adesso vivo viaggiando e lavorando da remoto… O almeno ci provo!
1. Come mai in un momento difficile della tua vita hai deciso di partire per fare volontariato?
Alla fine del 2015 mi sono trovata da sola dopo anni. Sentivo un vuoto che stentavo a riempire, nonostante mi buttassi a capofitto nel lavoro, nelle uscite con gli amici, nella “movida” londinese inebriante di alcol, musica e nottate fuori. Ho sempre seguito con interesse le vicende della cosiddetta “crisi” migratoria acuitasi in Europa proprio a partire dal 2015, e specialmente le vicende del campo rifugiati “Giungla” a Calais, così vicino a me, eppure così assurdamente lontano. Nel 2016 sono andata tre volte al campo, dove ho lavorato sia nello smistamento di donazioni e in cucina, sia con i bambini, principalmente di etnia Kurda, nel “Children’s Centre” nel cuore della Giungla. Tornata a Londra, non ero più la stessa. Non mi capacitavo di come la gente potesse continuare la propria vita, imprecando per un autobus in ritardo o una metro troppo piena, quando a tre ore di distanza famiglie intere vivevano in una palude in abitazioni fatte di tela cerata senza acqua né servizi. E questo dopo aver sofferto torture e soprusi in un viaggio che risulta mortale per così tanti altri. Ho capito che in quel momento la mia vocazione stava nel rendermi utile dove possibile: non per eroismo, intendiamoci, ma spinta da un desiderio forse ingenuo di “bilanciare” l’ingiustizia e l’ineguaglianza sociale rinunciando a certi miei privilegi per cercare di garantire le basilari necessità di altri esseri umani.
2. Cosa dà il volontariato che altre esperienze non danno?
Di certo il volontariato apre gli occhi alle miriadi di situazioni e di modalità di vita al di fuori della nostra limitata cerchia di famiglia e amici. Non basta guardare il telegiornale ogni giorno, condividere articoli su Twitter e indignarsi su Facebook quando succede qualche ingiustizia: tutto ciò rischia di desensibilizzarci, e inconsciamente ci fa prendere le distanze dagli eventi stessi. L’unica speranza secondo me è nella testimonianza in prima persona e nell’azione del singolo, e credo fermamente che ogni minimo gesto fatto per amore degli altri sia “volontariato”: basta fare la spesa per la vicina anziana, distribuire i pasti alla mensa per i senza tetto, fino a iniziative più impegnative come il volontariato nei campi rifugiati o in paesi del cosiddetto “terzo mondo”. Questo tipo di esperienze arricchisce chi dona sé stesso, tanto quanto chi riceve l’aiuto, anzi: spesso e volentieri il volontario riceve ancora più di quello che dà. Fare volontariato annienta l’arroganza, sconfigge i pregiudizi e distrugge gli schemi mentali nei quali la società in cui viviamo ci spinge a incatenarci, aiutata dal nostro spesso inconscio egoismo e dalla paura dell’ignoto che caratterizza il genere umano.
3. Che tipo di esperienze hai fatto in Africa di Volontariato?
Forte dell’esperienza di volontariato a Calais, e dopo aver contratto il “Mal d’Africa” a seguito di una visita in Malawi nel 2015, e poi in Uganda e Kenya nel 2016, ho deciso di lasciare il mio lavoro e l’appartamento a Londra, ho venduto o dato via buona parte di ciò che avevo, e ho comprato un biglietto di sola andata per il Malawi, dove sono rimasta da gennaio 2018 a febbraio 2019. Per i primi sei mesi insegnavo inglese in una scuola secondaria in una zona rurale (https://www.facebook.com/
ChimbotaPrivateSecondarySchool
/) e vivevo con una famiglia nella loro casa di villaggio, poi ho collaborato con una piccola associazione senza scopo di lucro italiana (
aroundawt.com), dove gestivo i loro progetti tra i quali una scuola primaria, un laboratorio di computer e dei corsi per le donne nel villaggio.
4. Quale è stata quella che ti ha segnato di più?
Senza dubbio i primi sei mesi sono stati i più formativi. Vivere in un villaggio rurale del Malawi, senza acqua né elettricità è stato sorprendentemente facile dopo i primi giorni di assestamento. In realtà, la famiglia con cui vivevo faceva tutto (prendere l’acqua al pozzo, tagliare la legna, cucinare, ecc.), cosa che spesso mi faceva sentire un po’ in colpa. Per quanto vivessi con loro, ero pur sempre un ospite, e tutte le volte che provavo a collaborare (per esempio andare a prendere l’acqua al pozzo, per l’ilarità generale dei bambini e lo stupore dei grandi) finiva sempre in un mezzo disastro, come la volta che ho provato a cucinare la nsima (polenta di mais che è il pane quotidiano di tutto il Malawi) e l’ho bruciata sul fondo, rendendola immangiabile e ritardando la cena di tutti! Al di là delle logistiche e le “scomodità” della vita in un villaggio, ciò che mi ha veramente segnato è stata l’accoglienza e l’apertura mentale e socio-culturale della famiglia e della comunità circostante. Nonostante le barriere linguistiche (l’unica che parlava inglese bene era la figlia undicenne, poiché frequenta una scuola primaria con insegnanti inglesi), mi sono sentita veramente accolta e fatta parte integrante della vita quotidiana familiare. Dopo scuola tornavo a casa verso le tre o quattro, facevo un po’ di compiti con i ragazzi della famiglia, poi c’era da fare il bagnetto ai più piccoli, da preparare la cena (io al massimo prendevo le ciotole e il piatto per me!) e infine la serata si concludeva con una partita a carte, un po’ di lettura del libro Paddington che un mio caro amico di Londra mi aveva regalato per usarlo a scuola, e la domenica sera, il cinema con la visione di un film Dinsney sul mio portatile, un evento molto atteso e al quale partecipavano altre due o tre famiglie circostanti!